Il busto restaurato di Antonio Allegri
Le travagliate vicende del presunto busto di Antonio Allegri detto il Correggio
La storia del busto del Correggio, oggi nuovamente esposto al Museo Civico di Correggio, è una vicenda affascinante e ricca di colpi di scena, che attraversa più di due secoli di storia cittadina, mescolando devozione artistica, fervore patriottico, equivoci eruditi e, infine, una sorprendente rinascita.
Il Settecento e la nascita del mito civico del Correggio
Negli anni Ottanta del Settecento, la città di Correggio viveva un periodo di vivace trasformazione politica e culturale. Sotto il governo del conte Vincenzo Fabrizi e l’autorità del duca Ercole III d’Este, le soppressioni dei conventi e la nascita di nuove istituzioni civiche segnavano il passaggio dallo spirito religioso a quello illuminato.
In questo clima, anche la memoria del più celebre concittadino, Antonio Allegri detto il Correggio, venne riscoperta e trasformata in simbolo identitario e culturale. Il duca volle infatti dedicare il nuovo Collegio e Scuola di Belle Arti di Modena al grande pittore, che incarnava il genio artistico delle terre estensi.
Nel 1786, per imitare l’Accademia di San Luca di Roma — dove si venerava il teschio di Raffaello — il duca ordinò che si rintracciassero le spoglie del Correggio, sepolto secondo la tradizione nella Chiesa di San Francesco. Dopo ricerche infruttuose e scavi condotti in tutta fretta, il governatore Fabrizi e i notabili locali dichiararono di aver trovato le ossa del pittore. Il cranio venne inviato a Modena per essere esposto nella Scuola di Belle Arti, mentre le ossa rimanenti furono conservate a Correggio in un piccolo monumento commemorativo, accompagnato da un busto che ne raffigurava l’effigie.
Il busto del Correggio: un omaggio tra arte e devozione
Il busto, acquistato nel 1788 a Modena per 180 lire, fu collocato con solennità nella “Pubblica Residenza”, l’antica sede comunale. Secondo una plausibile attribuzione, la terracotta fu realizzata dallo scultore Sebastiano Pantanelli (Pesaro 1731 – Modena 1792), docente di “plastica” nella neonata Scuola di Belle Arti modenese.
La figura ritrae un uomo dai tratti sereni, il volto pieno e aperto, i baffi sottili, lo sguardo fiero e luminoso: un’immagine lontana dal Correggio malinconico e introverso tramandato dalla letteratura artistica precedente. In questo senso, il busto riflette lo spirito positivo e razionale del suo tempo, in cui l’artista diventa non solo genio ispirato, ma modello di virtù e cittadinanza.
Nella parte cava del busto vennero collocate alcune ossa — ritenute, non senza forzature, appartenenti all’Allegri — trasformandolo così in una sorta di reliquiario laico. L’opera, esposta nella sala consiliare, divenne simbolo dell’orgoglio civico correggese e testimone dell’amore per l’arte e la memoria locale.
Dall’oblio ottocentesco alla rovina
Nel corso dell’Ottocento, il monumento perse progressivamente importanza. Con l’Unità d’Italia e la nascita del culto patriottico dei nuovi eroi nazionali, l’antico busto del Correggio apparve superato, persino imbarazzante.
Quando venne realizzato il grande monumento dedicato all’artista in piazza San Quirino nel 1880, le ossa furono spostate nel basamento della statua, opera di Vincenzo Vela.
Nel 1879 il busto venne rimosso per far posto a un nuovo busto di re Vittorio Emanuele II e trasferito negli archivi comunali, dove rimase dimenticato per decenni.
Nel tempo, la sua immagine fu considerata poco attendibile dal punto di vista iconografico: si giudicò che il volto rappresentato fosse troppo lontano da quello ritenuto autentico del pittore, e l’opera finì relegata ai margini della memoria cittadina.
Durante il Novecento il busto venne più volte spostato, fino a essere collocato nei depositi del Palazzo dei Principi. Lì, nel 1996, la forte scossa di terremoto del 15 ottobre lo fece precipitare al suolo, frantumandolo in numerosi pezzi. Si pensò che i frammenti fossero andati perduti per sempre.
Il ritrovamento e il restauro
Solo molti anni dopo, in circostanze del tutto inattese, parte dei frammenti fu ritrovata tra i beni del professor Ugo Bizzarri, studioso e appassionato collezionista locale. Grazie alla sensibilità dell’Associazione Amici del Correggio e del Museo Civico Il Correggio, le parti superstiti furono affidate alla restauratrice Roberta Notari, che con grande competenza e pazienza ne ha ricomposto la forma originaria.
Il restauro, accuratamente documentato, ha restituito unità e leggibilità all’opera, rendendo di nuovo visibile un pezzo importante della storia artistica e civica di Correggio.
Un ritorno significativo
Oggi il busto del Correggio è tornato a essere parte integrante del percorso espositivo del Museo Civico. Nonostante la sua non eccelsa qualità artistica, l’opera possiede un valore straordinario: è memoria tangibile della venerazione che la città ha sempre nutrito per il suo figlio più illustre e testimonianza delle complesse dinamiche tra storia, mito e identità.
Bibliografia: VALTER PRATISSOLI, Le travagliate vicende di un presunto busto di Antonio Allegri, Correggio Produce 2023, Correggio, pag. 95 – 105
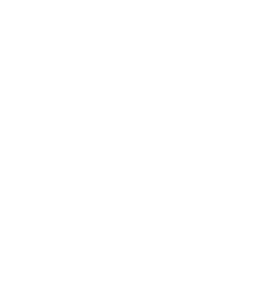 Museo Il Correggio
Museo Il Correggio 
