La Circoncisione di Gesù
Fino al 1972 il modenese Francesco Madonnina (1561- 1591) era considerato un “pittore senza quadri”. Fino ad allora infatti nessuna sua opera era stata identificata. Fu merito dello storico dell’arte Giuliano Frabetti l’essere riuscito a collegare con certezza, nel suo libro Manieristi a Ferrara (1), pubblicato appunto nel 1972, il nome di Madonnina ad un dipinto fino ad allora assegnato all’ambito del pittore ferrarese Giuseppe Mazzuoli detto il Bastarolo (1536-1589) (2). Si tratta della pala d’altare della Madonna del Rosario circondata dai Misteri, oggi conservata nel Museo Civico di Correggio, ma allora ancora presente nelle chiesa correggese di S. Giuseppe Calasanzio, in origine intitolata a S. Domenico. Frabetti aveva intuito che una notizia riportata dall’erudito Luigi Pungileoni nel 1821 (3), in cui si rendeva nota l’esistenza di un contratto di allogazione al Madonnina per l’esecuzione di una pala destinata alla Compagnia del Rosario di Correggio per un compenso di 65 scudi, si riferiva proprio all’opera nella chiesa correggese.
Il suddetto contratto, ritenuto per lungo tempo smarrito, fu poi rintracciato nell’Archivio Notarile di Correggio e pubblicato nell’anno 2000 da Valter Pratissoli (4). Questo documento permetteva di datare al 1589 l’anno di commissione della pala, consentendo di fissare un punto fermo nell’attività del pittore modenese. L’opera, ora nel Museo Civico di Correggio, rivela influenze correggesche nella Madonna col Bambino, si esprime con una pittura rifinita e controllata e rivela un sottile legame con l’ambiente correggese nella figura dell’Imperatore inginocchiato, letteralmente copiato dall’incisione I cordoni di San Francesco, realizzata da Agostino Carracci (1557- 1602) nel 1586 e dedicata al Correggese Niccolò Cicaglia, allora Padre Generale dell’Ordine Francescano (5).
Nei quattordici piccoli quadri con i Misteri del Rosario che circondano la tela centrale (6) il pittore scioglie la calcolata finitezza della pala in una pittura spezzata e compendiaria, con squillanti accensioni di colore sugli sfondi scuri (7).
Il Madonnina, esponente del tardo manierismo emiliano, mostra affinità con il già menzionato Bastarolo nelle opere di grandi dimensioni, mentre nei quadri di piccolo formato rivela tangenze con il bolognese Bartolomeo Passerotti (1529-1592), che spesso metteva in dubbio l’ufficialità della rappresentazione con notazioni anticonformiste. Ma Madonnina potrebbe anche essere considerato una sorta di “alter ego” di un altro pittore modenese, Domenico Carnevali ( 1524-1579), tanto è vero che esistono quadri di attribuzione altalenante fra i due artisti, come il San Michele Arcangelo della chiesa di S. Adriano a Spilamberto (8) e la Presentazione al tempio delle Gallerie Estensi di Modena, attualmente esposta nel Palazzo Ducale di Sassuolo (9) e probabilmente in origine nella chiesa di S. Domenico a Correggio. Madonnina ebbe certamente un rapporto privilegiato con l’ambiente domenicano correggese, tanto è vero che il Museo Civico di Correggio conserva, oltre alla già citata Pala del Rosario, altre due tele in origine in S. Domenico. Si tratta del San Michele Arcangelo che sconfigge il demonio (10), dove l’elegante figura dell’angelo spicca su una luminosa circolarità dorata, già presente nella Pala del Rosario, e del San Pietro Martire (11), dove il santo domenicano è raffigurato in adorazione della Croce di Cristo, alla quale sono appesi i simboli della Passione.
La Circoncisione di Gesù in esame (12) fu pubblicata con certa attribuzione al Madonnina nel 1995 da Angelo Mazza (13), il quale ricordava una vecchia presenza del quadro nella collezione Cavazzoni di Carpi.
Mazza metteva in evidenza le fortissime affinità, sul piano stilistico e iconografico, della piccola tela con la Presentazione al tempio facente parte della serie dei Misteri del Rosario che attorniano la grande ancona correggese. Immagini nervose e guizzanti, con un che di frenetico nella figura del sacerdote, mentre la torsione dell’inserviente con il bacile a sinistra può ricordare le posture di certi personaggi dipinti del già ricordato Passerotti, come soldati in primo (14) piano nella piccola Resurrezione della Pinacoteca Nazionale di Bologna.
C’è da rivelare che della tavola in esame esiste, in collezione privata, il disegno preparatorio su carta, molto rifinito (penna, inchiostro, inchiostro acquerellato), già attribuito a Raffaello Motta, detto Raffaellino da Reggio (1550-1578), il pittore reggiano che svolse gran parte della sua breve attività nel Lazio. Nel disegno tutti personaggi sono già collocati come nel quadro, così come l’anfora, presumibilmente d’argento, appoggiata sul gradino. Occorre inoltre evidenziare che esiste un’incisione di Cornelis Cort (1533-1578), fiammingo residente in Italia, datata 1568 e raffigurante la Presentazione al tempio, che può avere offerto spunti al Madonnina per la sua composizione, come lo spazio compresso e la presenza del lampadario e delle candele accese (15). La datazione della Circoncisione può essere orientata verso il 1590-91, al termine della breve vita del pittore, parallelamente ad un’esatta replica della tavola in esame. Si tratta di una piccola tela orale (ma resecata da un originale formato rettangolare) della chiesa di S. Lorenzo a Quingentole e depositata nel Museo Diocesano di Mantova, facente parte di una serie dei Misteri del Rosario, in cui il soggetto de La Circoncisione di Gesù ha sostituito il più frequente soggetto della Presentazione al Tempio (16).
Gian Paolo Lusetti
NOTE BIBLIOGRAFICHE
1. Frabetti, Manieristi a Ferrara, Cassa di Risparmio di Ferrara, 1972, p.68.
2. Ghidiglia Quintaralle, Scheda, in Ritrovamenti e restauri a Correggio, Parma, “La Nazionale”, 1959, pp. 11-12
3. Pungiglioni, Memorie storiche di Antonio Allegri detto il Correggio, III, Parma, 1817-21, pp. 31-32.
4. Pratissoli, Storie di quadri, in “Correggio produce”, 2000, pp. 103-108.
5. Per l’incisione di Agostino Carracci: D. De Grazia, Le stampe dei Carracci, Bologna, Nuova Alfa, 1984, p.. 148-149.
6. I Misteri del Rosario sono in realtà 15 (5 gioiosi, 5 dolorosi, 5 gloriosi), ma il quindicesimo mistero, l’Incoronazione, non è dipinto da Madonnina, ma da un pittore di assai più basso livello.
7. Per la Pala del Rosario: G. P. Lusetti, V. Pratissoli, Scheda, in Il Museo Civico di Correggio, Milano, Electa, 1995, pp. 67-70; E. Negro, L’eredità delle antiche pitture sassolesi nell’arte del Cavedone, in E. Negro, N. Roio, Giacomo Cavedone, Modena, Artioli, 1996, pp. 16-22; G. P. Lusetti, Momenti della pittura a Correggio tra XV e XVIII secolo, in Correggio dei Principi, Reggio Emilia, Nuovagrafica, 2009, p. 114.
8. Per il San Michele di Spilamberto: E. Negro, L’eredità… cit., pp. 15-18; A. Mazza, Scheda, in L’esercizio della tutela. Restauri tra Modena e Reggio Emilia (1985-1998), a cura di L. Bedini, J. Bentini, A. Mazza, Modena, Artioli, 1998, pp. 187-189.
9. Per la Presentazione al tempio delle Gallerie Estensi: E. Negro, L’eredità… cit., pp. 11-16: A. Mazza, L’esercizio… cit., p.189.
10. Per il San Michele di Correggio: A. Mazza, L’esercizio… cit., pp. 72-73; F. Pedrocco, Scheda, in La potenza del bene. San Michele Arcangelo nella grande arte italiana, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 82-83.
11. Per il San Pietro Martire: E. Negro, L’eredità… cit., pp. 21-24.
12. Secondo la tradizione ebraica la cerimonia della circoncisione avveniva otto giorni dopo la nascita del bambino; la cerimonia della presentazione al tempio (detta anche purificazione o candelora) quaranta giorni dopo.
13. Mazza, La pittura a Modena e Reggio Emilia nella seconda metà del Cinquecento, in La pittura in Emilia e in Romagna. Il Cinquecento, II, a cura di V. Fortunati, Milano, Electa-Credito Romagnolo, 1995, p. 195.
14. Per la Resurrezione di Passerotti: A. Ghirardi, Scheda, in Pinacoteca Nazionale di Bologna. Catalogo generale, II, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 150-151.
15. Per l’incisione di Cort: J. Winkelmann, Giovanni Battista Ramenghi, in Pittura bolognese del ‘500, II, a cura di V. Fortunati Pietrantonio, Bologna, Grafis, 1986, pp. 434-446.
16. Brunelli, in Museo Diocesano di Mantova, 1983, nn. 100-114.
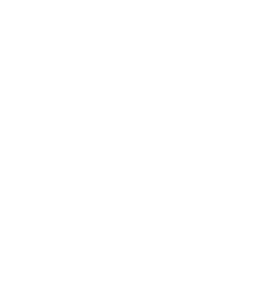 Museo Il Correggio
Museo Il Correggio 
